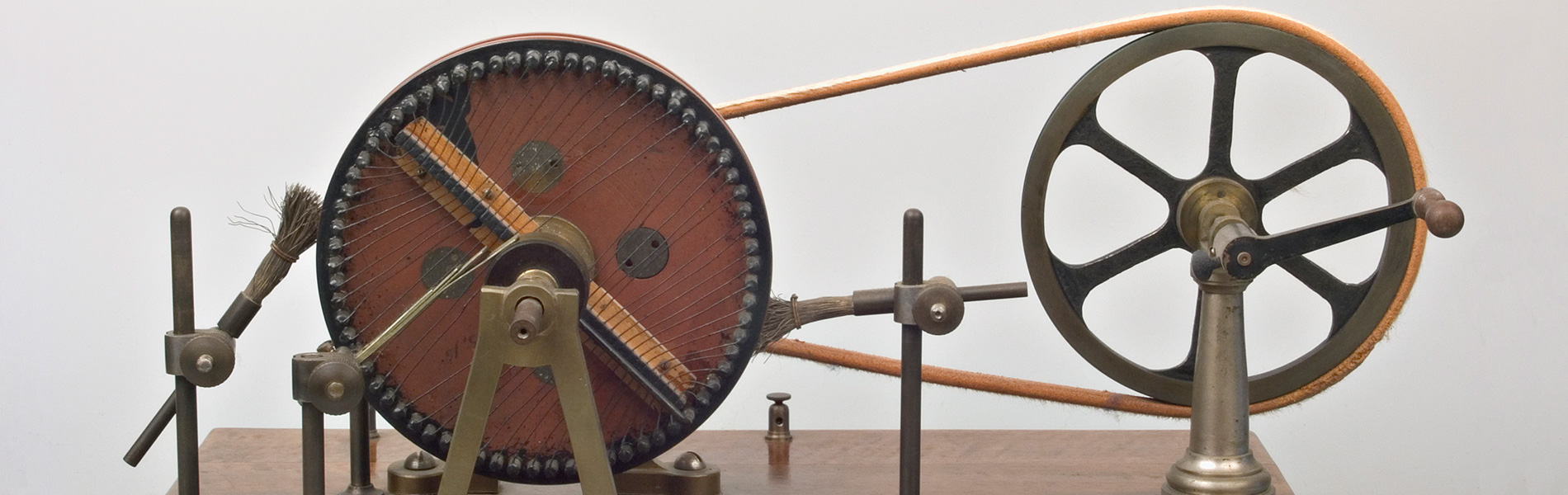tela/ pittura a olio
sec. XVIII (1710 - 1720)
La tela, inedita fino al 1993 (cfr. Viroli 1993) e conservata in palazzo Spreti fino al 1913 (elenco conservato alla Classense, Armadio 5.K5/32), è stata visibilmente ridotta nelle zone laterali, forse per via del forte degrado sopraggiuntovi, come si evince anche dal citato elenco che riportava delle misure differenti (cm. 240 x 300 piuttosto che le odierne 240 x 211). L'episodio rappresentato è tratto dal libro della Genesi (40; 41, 1-45): Giuseppe, durante la detenzione in Egitto, sviluppò la capacità di interpretare i sogni dei suoi compagni di cella, il capo dei panettieri e quello dei coppieri. Dopo due anni, il capo dei coppieri, che nel frattempo era stato reintegrato nelle sue funzioni (al contrario di quello dei panettieri, giustiziato), segnalò Giuseppe al Faraone che era rimasto gravemente turbato da taluni suoi sogni. Gli episodi onirici del monarca, quali le sette vacche magre che mangiano le sette vacche grasse e le sette spighe secche che inghiottono le sette spighe piene, sono da considerarsi un monito per Giuseppe, vale a dire che annunciavano sette anni di prosperità cui sarebbero succeduti sette anni di carestia. La predizione fece guadagnare a Giuseppe la carica di ministro con l'incarico di provvedere alle scorte dei raccolti in previsione dei periodi di magra: il Faraone si tolse dal dito l'anello che corrispondeva al suo sigillo e lo pose nella mano di Giuseppe che fu anche coperto da un telo di lino finissimo e gli donò un monile d'oro da appendere al collo. Effettivamente la carestia che si verificò in Egitto non causò fame nel paese. Nonostante il dipinto versi in pessime condizioni, per via delle notevoli cadute di colore, soprattutto nalla figura di sinistra e nel dignitario barbato al centro, che in parte ne compromettono una corretta lettura stilistica, Viroli lo attribuisce a Francesco Mancini (1993). L'impronta che si coglie è quella di un forte richiamo ai modelli classicisti e seicenteschi, sì familiari all'artista. Queste peculiarità consentiranno a Mancini di primeggiare, oltreché in Romagna, anche a Roma dove riesce ad affermarsi con un linguaggio senz'altro più originale rispetto a quello utilizzato da altri artisti non capitolini, quali i valenti Sacchi. L'esposizione sintetica ed essenziale della scena, seppur debitrice degli influssi di Cignani, suo maestro, e della pittura emiliana coeva, paiono quasi annuciare il Neoclassicismo, calcando i momenti fondamentali di quella linea figurativa che giunge sino alle sue soglie passando per Batoni e Luti. Circa la datazione, l'opera, che nell'astante di sinistra ricorda il San Pietro del Domine Quo Vadis (?) della Pinacoteca di Città di Castello, per la quale non si hanno indicazioni cronologiche precise, viene ricondotta da Viroli allo stesso momento delle altre opere di Mancini presenti nella Quadreria Classense, cioè gli anni dieci del Settecento. La tela è stata restaurata nel 1997 dal Laboratorio del Restauro di Ravenna.